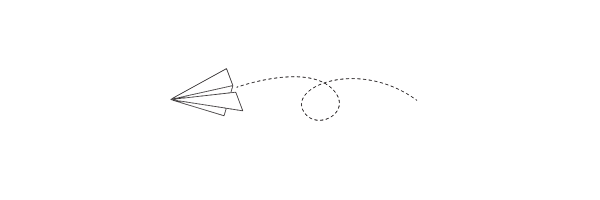#57. Flussi elettrici
La "sinfonia infernale" di Bosch, l'eredità di Nikola Tesla e la rivoluzione di Rudolf Nureyev: tre figure unite nel flusso vitale (e musicale) da loro creato, ancora oggi vibrante.
Ciao !
Qual è stata la prima musica che hai ascoltato nel nuovo anno? La mia è la Messa di requiem in Re minore K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart: niente male, vero?
L’opera è incompiuta, Mozart si spegne con l’inchiostro della partitura ancora fresco sulle dita; sarà poi completata dall’amico e allievo Franz Xaver Süßmayr. In particolare, è proprio quest’ultimo a chiudere il Lacrimosa: brevi frasi musicali, dove l’intreccio tra archi e coro si eleva ad anelito verso il divino. Del resto, se c’è un modo per sfiorare l’ultraterreno, lo si trova nella musica di Mozart.
Divagazioni filosofiche a parte, dovremmo impegnarci a scrivere partiture, non importa se saranno o meno finite, se ne abbandoneremo una per iniziarne un’altra, se avremo bisogno (spoiler: ne avremo, eccome) di alleanze per portare a termine la nostra opera: l’auspicio è di guardare oltre, lasciare un segno nel mondo, stringere sodalizi e uscire di casa, dalle mura che ci proteggono, per cambiare ciò che non va e illuminare un fosco presente.

In questi giorni, cadono un paio di anniversari, la scomparsa di artisti che hanno cambiato l’ordine precostituito, con audacia e coraggio: sono Nikola Tesla e Rudolf Nureyev, la loro eredità è più accesa che mai. E poi c’è un pittore fiammingo, in mostra a Milano, che torna a vivere in un’opera audiovisiva e tra le pagine di un graphic novel.
L’inferno musicale di Bosch
L’incubo si muove sulla tela, i tessuti pulsano, il fluido galvanico di note elettroniche porta alla vita forme e figure: le suggestioni sonore di Fernweh infondono vita a corpi bidimensionali, legando immagini e suono. L’opera audiovisiva Tríptiko. A vision inspired by Hieronymus Bosch, realizzata da Karmachina, è un’immersione nell’universo visionario del pittore fiammingo e la musica ne costituisce parte viva. È ispirata al celebre Trittico del Giardino delle Delizie, un olio su tavola che può essere ammirato al Museo del Prado di Madrid.
In particolare, nella predella destra, Hieronymus Bosch rappresenta l’inferno. La peculiarità del paesaggio demoniaco, particolarità che balza subito agli occhi, è il suo essere zeppo di strumenti musicali. Ci sono — trascrivo i primi che noto, dando una veloce occhiata al dipinto — liuto, arpa, ghironda, triangolo, tamburo, tromba, flauto, ciaramella, cornamusa. Nella cacofonia generale, che sembra irrompere e sconvolgere i sensi di chi osserva, c’è poi un dettaglio che, da sempre, attira l’interesse di appassionati e curiosi: laggiù, nell’angolo in basso a sinistra, ecco delle natiche su cui è disegnato uno spartito.
Qualche tempo fa, sono iniziate a circolare in rete diverse interpretazioni della partitura che, per l’appunto, riproduce una vera e propria melodia, conosciuta come Butt Song o Butt Music (esatto: la canzone, o musica, del culo).
Le opere di Bosch sono disseminate di riferimenti musicali — strumenti, artisti, partiture — e, se vuoi approfondire, ti consiglio un paio di letture (in inglese):
L’abilità onirica e il talento visionario di Bosch, da secoli, incantano e ossessionano artisti di ogni genere. Tra questi, Hurricane, al secolo Ivan Manuppelli, in occasione della mostra a Palazzo Reale di Milano, disegna un graphic novel dal titolo oscuro, ispirato proprio al genio fiammingo: Sinfonia Infernale. Concerto in Bosch minore (24 Ore Cultura, 2022). La storia ruota intorno a un misterioso disco, acquistato dal protagonista perché affascinato dalla copertina, un disco il cui ascolto avrà delle conseguenze peculiari.
Nota a margine: la mostra Bosch e un altro Rinascimento si tiene a Milano, nelle sale di Palazzo Reale, fino al 12 marzo 2023 (è spesso affollata, ma val bene una visita).
Il canto elettrico di Nikola Tesla
È ricordato per gli innumerevoli contributi nel campo di elettricità ed elettromagnetismo, i suoi brevetti e le sue invenzioni plasmano, ogni giorno, il mondo contemporaneo: eppure, Nikola Tesla muore in solitudine e povertà il 7 gennaio 1943, ottant’anni fa.
Tesla è noto per le ricerche all’avanguardia; il sistema elettrico a corrente alternata, parte imprescindibile della nostra quotidianità, affonda le origini proprio nelle sue intuizioni, così come è possibile scovare tra i suoi esperimenti scintille di alcune delle moderne tecnologie, come il wi-fi.
Tra le creazioni, c’è la bobina di Tesla, un trasformatore risonante ad alta tensione: in sostanza, uno strumento in grado di generare scariche elettriche aeree, fulmini del tutto simili a quelli atmosferici, che trasmettono energia elettrica senza fili. Un macchinario affascinante — ce n’è uno al Museo Nikola Tesla di Belgrado, se passi di lì — e che il team di Franzoli Electronics ha deciso di applicare alla musica:
Come spiegano loro stessi nelle didascalie dei video, le musiche sono create tenendo in considerazione diversi fattori come, ad esempio, la frequenza di accensione e la larghezza degli impulsi. È un canto elettrico, il canto di Tesla, la sinfonia primordiale della vita che scaturisce dagli impulsi energetici.
Secondo la mia modesta opinione, Tesla avrebbe apprezzato.
Divino e ribelle, come Rudolf Nureyev
Era un ribelle, anzi, era un’anima in lotta contro le convenzioni precostituite della danza, contro una divisione tra generi ostacolo dell’espressività, contro il dogma che prevede che le regole debbano restare immutabili. In perfetto equilibrio tra estro e disciplina, tempra e grazia, Rudolf Nureyev è stato un ribelle divino. Il 6 gennaio, si ricordano tre decenni dalla sua scomparsa.
Venuto al mondo su un vagone della Transiberiana, nei pressi di Irkutsk (località russa a nord della Mongolia), il 17 marzo del 1938; il suo mito nasce invece all’aeroporto parigino di Le Bourget, il 16 giugno 1963. La vita di Nureyev scorre da una ferrovia a uno scalo aereo, per poi conquistare palchi di tutto il mondo e venire proiettata su milioni di schermi, come se la regola di corpi in perenne movimento fosse da sempre un suo tratto distintivo, se l’energia fluisse continua e incessante in ogni sua fibra.
All’aeroporto di Parigi, quel giorno dei primi anni Sessanta, spicca il cosiddetto “salto verso la libertà”: mentre è in tournée con il Balletto Kirov, oggi Mariinskij, non rientra in patria — la Guerra è parecchio Fredda, a quei tempi —, bensì sceglie di restare in Occidente.
Da quel giorno, il suo talento deflagra e non si limita al balletto classico: quando danza Apollon musagète, nei primi anni Settanta, cambia i codici della danza contemporanea; è ballerino e coreografo, è la danza che si fa carne.
Di lui, Roberto Bolle ama ripetere che, quando lo si ammira danzare sul palco, tutto il resto sparisce, che con lui la danza assume un volto e un corpo, uscendo dai teatri per farsi icona.
C’è un film dedicato alla sua vita, The White Crow (lo puoi trovare su diverse piattaforme di streaming), diretto da Ralph Fiennes e basato sul romanzo biografico Nureyev. La vita, scritto da Julie Kavanagh e tradotto da Viviana Carpifave (La nave di Teseo, 2019).
Postilla: nel giugno del 2018, per celebrare gli 80 anni dalla sua nascita, scrivevo uno degli articoli più apprezzati del blog.
Per il Dispaccio di oggi è tutto.
Se hai voglia di condividere le tue idee, di lasciare il segno, di alzare gli occhi dallo schermo e accendere il mondo là fuori, se hai domande, consigli, se non dormi, se pensi che parole e musica possano e debbano cambiare il mondo: scrivimi.
Ah, con il prossimo appuntamento, torneranno gli Accenti.
A presto,
Samantha